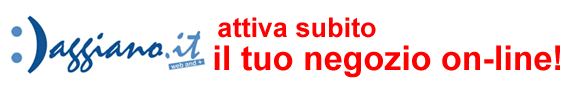La chiesetta rappresenta il tipico esempio di un luogo o edificio sacro (altrimenti destinato a sicura scomparsa) salvato dalla devozione popolare
Il 15 giugno scorso si sono rinnovate, in territorio di Torricella, le cerimonie religiose legate alla chiesetta rurale della SS. Trinità, a breve distanza dal paese. Ripropongo, di seguito, il contenuto di alcuni articoli da me editi in precedenza su tale evento (vedi “Liberamente”, quindicinale di informazione attualità e cultura, Manduria, anni 2003, 2007 e 2010) arricchito di ulteriori dati storici e territoriali.
Va innanzitutto sottolineato che la nostra chiesetta rappresenta il tipico esempio di un luogo o edificio sacro (altrimenti destinato a sicura scomparsa) salvato dalla devozione popolare.
Trovasi, tale cappella, in contrada Tremola, all’interno di una vasta proprietà terriera posta sul confine orientale di Torricella, lungo l’arteria che conduce a Maruggio.
Masseria Tremola, con i suoi vasti locali in abbandono, tradisce l’ampiezza dell’area agricola di pertinenza, mentre un grande frantoio ipogeo, posto alla base del corpo di fabbrica centrale ed una suggestiva colombaia presente sul terrazzo, meriterebbero ben altra tutela e valorizzazione (vedi P. TARENTINI, Torricella. Itinerari storico-archeologici a sud-est di Taranto, Manduria 2018, pp. 43-52).
La chiesetta della Trinità, a breve distanza della masseria, si erge su un’area leggermente a rilievo protesa su una vasta cava di tufi che ha profondamente segnato la contrada, giungendo quasi a lambire l’edificio sacro.
Lo scenario che da tale luogo si scorge è invero suggestivo, e spazia, a Nord, verso ampie distese di oliveti che sembrano volersi riappropriare degli spazi usurpati dalla cava; a Sud, una vastissima pianura verdeggiante di vigneti e di oliveti si distende verso i rilievi di Cravara e Monacizzo, carichi di storia e di “archeologia”; più in là, il mare, nascosto dalle basse dune litoranee.
La chiesetta in superficie (sub divo) della Trinità, in buono stato di conservazione, si sviluppa su un’originaria cripta ipogea sottostante, la cui scoperta si lega ad una leggenda fortemente radicata, pur con varianti, nelle memorie locali.
Ne trascrivo il testo edito dall’amico Mario ANNOSCIA, nel suo puntuale e sapiente studio dedicato a questo luogo storico, in forte polemica col tentativo (fortunatamente non riuscito) di trasformare le cave limitrofe in una discarica: ” All’imbrunire d’un giorno d’un anno imprecisabile una pastorella, che aveva menato le bestie al pascolo, s’accorse che una di esse, una mucca, postasi come in ginocchio, non si rialzava per riunirsi alle altre e fare ritorno alla stalla. La ragazza, fattasi molto curiosa e per la strana positura del mansueto animale e perché insolitamente restio ad obbedire all’usato richiamo, si avvicinò e, scostati gli steli dei fitti rovi lì davanti e le frasche d’altre piante spontanee, s’avvide stupita che v’era una fenditura nel terreno, un pertugio tra pietre ed erbe. Il giorno seguente volle tornare per meglio rendersi conto: rimosse alcune pietre e fatta più larga la fenditura, vide che c’era un anfratto che dava in una cavità sottostante. Allargato il passaggio, volle cautamente scendere e, alla fioca luce, intravide, dipinte sul muro, le figure della SS. Trinità . Corse in paese a dare la nuova e …” (vedi M. ANNOSCIA, , La chiesa ipogeica sotto il titolo della SS. Trinità in agro di Torricella (TA), in “lu Lampiune”, IX (1993), 1, pp. 211-217).
Dal momento della scoperta, la devozione popolare si è “impadronita” dell’ipogeo, tramandando ai posteri una significativo esempio di habitat (presumibilmente) altomedievale, reso ancor più “visibile” da quella chiesetta superiore realizzata, in epoca moderna, a suggello definitivo della sacralità del luogo.
Sacralità che rivive nelle cerimonie religiose celebrate la Domenica successiva alla festività della Pentecoste, con messa officiata nello spiazzo antistante la chiesetta, al cospetto di un folto numero di credenti e fors’anche di semplici curiosi, comunque rispettosi del luogo e particolarmente affascinati da tanta devozione e da così forte legame con le tradizioni.
Si scende con una certa curiosità nell’ipogeo, lungo una scalinata piuttosto agevole, resa più sicura da un corrimano, affiancata nel tratto terminale da tre gradini, forse di una gradinata precedente?
L’invaso si compone di un unico ambiente quadrangolare, a volta piana, scavato nella roccia, percorso tutt’intorno da uno zoccolo di base, più o meno sporgente, utilizzato come sedile. Al centro della cripta si pone un grande altare realizzato in tempi certo non antichi, addossato all’unico pilastro ricavato ai tempi dello scavo a sostegno del soffitto; alle spalle dell’altare, un lucernario dà luce all’ambiente, illuminando il candore delle pareti laterali imbiancate a calce; calce profusa a piene mani, forse a discapito degli antichi affreschi citati dalla leggenda e ricordati da una pur fioca tradizione storiografica (vedi P. TARENTINI, Il Medioevo a sud-est di Taranto: impianti rupestri e chiesette ipogee tra Lizzano, Torricella, Maruggio e Manduria, in QuaderniArcheo, 11(2020), pp. 11-13, in part. nota 21).
Sull’ altare, ornato di fiori e luci, si pone un quadro che rappresenta la SS. Trinità e la leggenda della pastorella, con, in basso, nell’angolo di sinistra, la scritta”DIMASI e DI MARIA fecero dipingere a loro spese il 1 Maggio 1899”. Un secondo quadro con l’immagine della SS. Trinità (in passato notato all’interno dell’ipogeo) è ora depositato nella chiesetta superiore.
Mentre si osservano le caratteristiche dell’ipogeo, alcune anziane devote recitano preghiere camminando, a passi lenti, intorno all’altare; consuetudine antichissima, confermata a più riprese dagli abitanti del posto, che riferiscono di una preghiera, in particolare, recitata durante tale cerimoniale: “Trinità, Maestà, Spiritu Santu, crazià e la crazia ca ti cerco mi la fai, pi carità. E fàmmila Maria e fàmmila pi pietà pi lu dono ca ricivisti ti la SS. Trinità. Scenni l’Angiulu ti n’cielu e ti veni a visitari e si ‘ncrina a Te Maria e ti tici l’Avi Maria”.
Tre sono i giri intorno all’altare accompagnati da tale invocazione; tre, come simbolo della Trinità.
Queste preghiere e questi riti vivificano ed esteriorizzano il profondo legame di fede con questo luogo ed una tavoletta lignea, osservata in anni precedenti sull’altare, richiama, nella scritta “A devozione alla SS. Trinità Però Cecilia e il popolo 28.5.1994” un ex voto per grazia ricevuta.
Questo legame e questa fede travalicano i meri ambiti comunali e ci portano a confrontare le cerimonie all’interno della nostra cripta con quanto segnalato nell’antichissima chiesetta di Gallana, in agro di Oria, ove il 14 Agosto, vigilia della festività dell’Assunta, si procede a tre giri intorno all’altare illuminato da 15 lampade ad olio, recitando un’antica nenia, nella fiduciosa certezza della protezione mariana(vedi G. DALFINO, G. MELE. Santa Maria di Gallana in agro di Oria. Storia e architettura, Bari, Adda Editore, 2005, p. 31). La stessa leggenda della pastorella di Torricella ne richiama un’altra, per molti versi analoga, presente in territorio lizzanese; leggenda, quest’ultima, che collega la scoperta della chiesetta semi-ipogea del Crocefisso (caratterizzante il centro storico di Lizzano ed anch’essa, forse, di origine medioevale) col comportamento alquanto strano di alcuni buoi che, arando il podere, parevano rallentare il passo e chinare il capo dinnanzi ai ruderi di antiche case abbattute; rimosse le macerie, si scoprì la chiesetta, meta di devozione e pellegrinaggio, sino a tempi non lontani, anche da parte di fedeli provenienti da paesi limitrofi (vedi F. BERZANO, La storia di Lizzano (Taranto), Asti 1950, ristampa anastatica – Pro Loco Lizzano, 2006, pp. 120-122).
Siamo, tanto a Torricella, quanto a Lizzano, in presenza di leggende antichissime che, unitamente ai racconti di “miracolosi” interventi operati dal “Divino” a difesa delle popolazioni della costa da assalti di Turchi e Saraceni, concorrono a tramandare vicende ed atmosfere di un mondo medievale forse non altrimenti riconoscibile, soprattutto in questi luoghi estremamente periferici, spesso emarginati dalla “ricerca” e dalla “Storia”.
Sono leggende che, toccando le corde estremamente sensibili del “sentimento religioso”, hanno svolto e continuano a svolgere, nei confronti di tanti luoghi storici e di culto del nostro Salento, una straordinaria funzione di conservazione e salvaguardia, con cui noi “moderni” siamo chiamati a confrontarci con le nostre capacità (e soprattutto volontà) di recupero, tutela e valorizzazione.
Tutela garantita, per la nostra chiesetta e per la località che la accoglie, da un decreto di vincolo archeologico posto dagli Organi competenti (anno 1995) con cui si fa divieto di un uso indiscriminato dell’area ai fini della conservazione e della tutela della stessa. Decreto confermato dalla Sentenza TAR Puglia, Lecce, sez. I, 14.1.2010, n. 157, che, nell’evidenziare la valenza dell’area, riassume, in breve, la documentazione archeologica proveniente dal sito. Prima di tutto una grotta, denominata “Grotta del Rospo” interna alle cave, caratterizzata da presenze neolitiche (ceramiche dipinte ed industria litica) del V-IV millennio a.C., circa; poi “ceramiche ad impasto della prima età dei metalli e ceramica acroma tornita del VI-IV sec. a.C.”; segue la cripta, che richiama le chiesette ipogee e gli impianti rupestri medievali sparsi sul territorio pugliese e materano a difesa dagli assalti pirateschi provenienti dal mare; infine la chiesetta di superficie, risalente (per data riportata nella citata Sentenza) al 1831, a testimonianza di una fede religiosa costretta nelle cavità rupestri dalle turbolenze del Medioevo, riemersa poi, in superficie, ancora più salda e forte, a conforto e sostegno di un popolo e di un territorio pienamente partecipe delle vicende storiche dell’epoca.
Si torna volentieri in questa chiesetta ed a questa celebrazione; ci si sente partecipi di una collettività colta in un particolare momento di aggregazione e di raccoglimento, in un luogo quasi fuori dal tempo e dallo spazio; un luogo certamente lontano dai rumori troppo assordanti ed aggressivi della “modernità” che in altri posti ha contaminato o cancellato tante tradizioni e consuetudini secolari, qui fortunatamente ancora vive e rispettate.
Un personale ringraziamento ai componenti il comitato impegnato ogni anno nell’organizzazione di tale cerimonia … per il rispetto delle tradizioni e per la tutela di un Bene Storico e di un’ Identità Territoriale da custodire gelosamente e da veicolare verso le generazioni future.
Paride Tarentini

 Condividi
Condividi