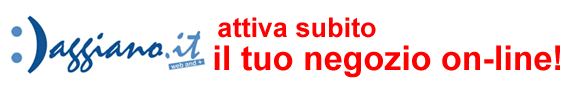E’ un percorso interiore che l’autore compie alla ricerca di un Sé che non trova il proprio posto nel mondo
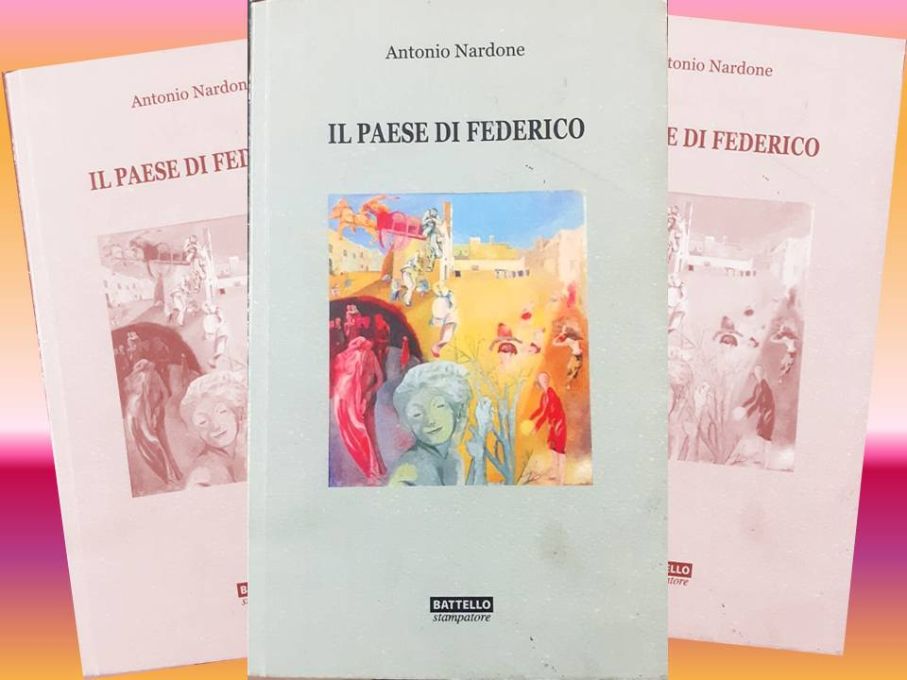
Destinazione Frederikland km 1150… “Il paese di Federico” è un percorso interiore che l’autore compie alla ricerca di un Sé che non trova il proprio posto nel mondo. Egli affida questa singolare ricerca al protagonista Uberto e alla sua incontenibile necessità di “riconsiderarsi”, all’interno di un vissuto (che poi è quello dell’Autore) che si avvita su se stesso, vorticosamente. Di qui le mirabili peregrinazioni di pensieri, immagini e ricordi esternati attraverso una scrittura ad alta frequenza, visionaria, descrittiva, ironica, poetica, in ultima analisi, catartica.
Una narrazione indomabile ci fa conoscere oltre Uberto, Adelina, Chiarina, Morella, invitando ad ogni passo il lettore a distogliere lo sguardo dalla pagina per fissarlo nel caleidoscopio della propria interiorità, ispezionando nel profondo la propria coscienza, non essendo altri, i personaggi, che sfaccettature di un unico ‘habitus’ mentale di valenza universale, quasi archetipica: l’insoddisfazione perenne, l’incapacità a ‘vivere’ le varie fasi della vita, a non ‘interpretarle’ solamente. I personaggi del libro, infatti, sono portatori sani di nomi e storie differenti, ma nell'economia del testo altro non sono che il coagulo di un solo nome e di una sola storia, quelli dell'Autore. Di più, di ogni lettore. Approdare ‘nel paese di Federico’ presuppone l’abbattimento di ingannevoli certezze acquisite (una per tutte, la «manigolda giovinezza») e l’utilizzo di coordinate poco gradite all’animo umano, perché terribilmente faticose da seguire.
Il paese di Federico è un paese dell’anima, anzi del cuore, quel cuore che, a furia di essere cercato a colpi di martello e scalpello, si sgretolò «scivolando in frantumi e rovinando nella polvere». «Che abbia un cuore è cosa assurda (…) le statue non hanno un cuore». Una statua? Federico, «di bell’aspetto, aria da svagato vagabondo (…) tronco ben eretto (…) labbra morbide e distese in un sorriso fisso e sempre uguale», una statua? «Che cercavate sotto quella camicia: un cuore? Federico era il cuore di tutte noi; ci sosteneva nelle quotidiane viltà e nei turbamenti che fiaccano l’anima. Corvi, che non avendo anima, godete ad aprire il petto ad ogni sogno per sopprimerlo sul nascere, squarciando a Federico il petto, l’avete squarciato a tutti noi!» — disse la Consigliera Tarentini (p. 9). Dopo il fattaccio, la statua non fu mai ripristinata, ma i suoi ammiratori crearono un paese tutto loro: il paese di Federico, paese ideale dove ogni cosa può accadere. E Uberto, passando di là, chiede una volta di più la ragione del suo «male al petto»: che il suo cuore si fosse sgretolato insieme a quello di Federico?
Nel paese in cui tutto può accadere, tutto accade. È una storia lunga e complicata che fatica a definirsi tale, perché è «un canovaccio che, ad ogni girata d’angolo, si adatta agli umori del protagonista». È Uberto, intrappolato tra «snervanti monologhi» o «serrati dialoghi con se stesso». Un’interlocutrice ci sarebbe, Adelina, se non fosse che ha fissato per sempre la sua esistenza a ventisei anni, facendo sembrare bizzarri i dialoghi che Uberto intesse con lei: «Ah, le tue solite uscite finte: sei uscito di casa senza mai uscire da te» (p. 15). Amare considerazioni ci fanno conoscere meglio l’invecchiato Uberto che parla ad Adelina: «A me gli anni hanno scavato fin nell’anima e, se mi guardo indietro, non mi riconosco e, visto che a guardami non mi ci ritrovo, quando sono allo specchio mi levo gli occhiali (…). E comincia un altro giorno… Fino a quando? E questa testa che non fa che raggomitolare il filo del tempo, quasi che esso non si sia sfilacciato una volta per sempre. “Rivivere il già vissuto non è un rimorire dove sei già morto?”, mille volte mi dico» (p. 17).
Siamo in viaggio con Uberto verso la Puglia, ma… ad arrivarci in Puglia! In viaggio, con gli occhi della memoria puntati sulla propria vita e con nessuno a dirigere il traffico dei pensieri, questi piovono copiosamente fra le pagine: «Reminiscenze in libertà come cani sciolti» — dirà più tardi Uberto. La nascita in treno, «presentando la fronte, già oppressa da mille sinistre preoccupazioni (…) un modo come un altro per nascere» (p. 21); l’incessante dialogo con Adelina, «io ho certezza e dannazione di non poter morire, perché sono morto quando sei morta tu, e, notoriamente, non si muore due volte» (p. 24). Il viaggio diventa metafora, la strada è quella per ritrovare se stessi: «per restituirsi agli affetti come avrebbe dovuto essere e non è stato. T’assicuro, il male che fa, a riconsiderarsi, è come cavarsi un dente senza anestesia (…)» p. 25».
È questa la cifra del libro: ricomporre un Sé irrisolto, sepolto sotto una montagna di detriti in fondo all’anima, ricomporlo con umiltà e pazienza e riflettere che «se così ci trova, è perché abbiam teso orecchio a sirene che non meritavano credito. Di credibili c’eravamo io e te (…) intendendo io e me: solo!» (pp. 51-52)». Non è più credibile Chiarina, «Chiarina, la giovinezza tua, te la sei giocata il giorno in cui ti è venuto meno il coraggio di viverla!» (p. 63); come anche non lo sono più “il Buono, il Carogna e il Bastardo”, trio indissolubile: «anzi, eravamo un tutt’uno; eravamo… uno! Poi, sbeffeggiati da un nemico accampato al nostro interno (…) venne il tempo della diaspora» (pp. 65-67). E venne la morte per ‘Bastardo’, suicida perché fiaccato dal gioco della vita: fu allorquando «prese coscienza che il proprio vagare era stato un correr dietro a un soffio» [Chiarina]. Tutto ciò che c’era di amabile era finito per sempre, «e si trovò fra le mani un bicchiere vuoto, un sé sporco al fondo di feccia»: Chiarina era divenuta Morella, la gioia di vivere aveva lasciato il posto all’ombra della sera: «mestizia d’una indecifrabile giovinezza» (p. 69).
E’ un Io che prende le distanze da se stesso, dopo aver tanto lottato: «(…) ma ora non voglio più stanarlo (…) Mi è utile così com’è, vile sagoma a due trampoli, per poter dire di me che io non sono lui, e rifilare a lui tutte le mie viltà e negligenze. (…) Viva la vita, ohibò! Quale gioco più intrigante? Viva la scorza, che dà volume al tronco cavo, lasciandoti libertà assoluta di bleffare. Gallo cedrone, è tempo degli amori: su, vesti le piume più sgargianti e dimentica per un brevissimo istante d’esser pur sempre… un gallo» (pp. 86-87).
Si procede, a piccoli passi, verso ‘il paese di Federico’. «Quanti anni, quanti rattoppi al fondo dell’anima, quanti rappezzi alle camere d’aria per arrivare ogni volta in rimessa a riprender fiato: e tutto e solo fino alla prossima foratura!...» (p. 70). «Laggiù c’è un mondo racchiuso fra parentesi, morto ma che insiste a risalire alla ribalta attraverso suoni e voci mai sopiti (…) È un posto al limite del mondo, ombelico del mio mondo, abitato da miraggi e fantasmi» (p. 33), ma tanto tanto affollato.
C’è Vittorino, nel suo ‘ufficetto’ a guardia del ghetto; c’è Filumena che piange il figlio diciottenne morto in sella alla moto guidata dal suo amico Nicola: «Eppure era una strada dove non serviva la lampara, a che serve — disse Nicola — «sopra una strada per dove passo io e me». Invece è proprio fra l’ ‘io’ e il ‘me’ che talvolta si muore. E un amore, quello di Nicoletta che «ancor che nascere era già morto». C’è Ninu, a cui piaceva il Charleston ma che invece di emigrare in America emigrò in Olanda per lavorare in ferriera» (p. 40). E c’è sempre Uberto che viaggia (insieme al lettore) verso il grembo materno di un tempo ormai scaduto: «esiste un posto dove si radicano i ricordi: il luogo della gioventù, dei giorni senza tempo, del tempo delle cicale, il luogo da cui, in fondo, non t’allontani se non in linea d’aria e che ti porti attaccato addosso come abito su misura per le strade di Milano o di Torino, di Trieste o di Nuova York: è il ‘Paese di Federico’ luogo favoloso ed esclusivo, stanza inviolabile, dove ha termine il tuo esilio da te, e vi torni tutte le volte che puoi, a riporci l’anima» (p. 76). Un po’ come si fa con la madre: «Corri, mamma, corri: la tomba non è fatta per restarci dentro!». «Dolcezza di quegli occhi, che spalmo a mo’ di caramello sul pan secco dei miei anni».
È poesia! Tutto nel paese di Federico è poesia, metafora e sogni partecipati! E mentre per andare a Quiquì si va di qui e per andare a Quaquà si va di là, per il paese di Federico «c’è una sola strada ed è l’innocenza» (p. 48).


 Condividi
Condividi