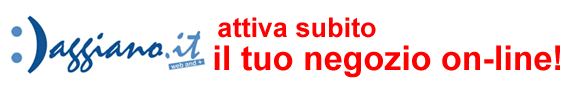E’ una lettura drammaticamente ricca di Storia, quella del popolo armeno, vittima della persecuzione turca del 1915
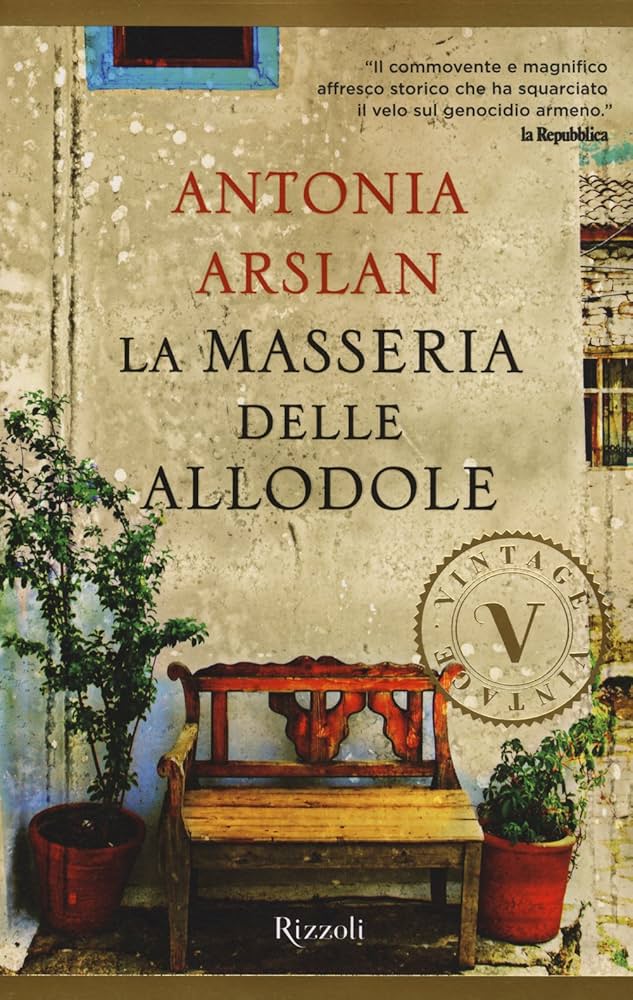
“La masseria delle allodole” è una lettura drammaticamente ricca di Storia, quella del popolo armeno, vittima della persecuzione turca del 1915. È la storia di una famiglia benevola e accogliente tanto da abbracciare un'intera comunità. È la forza e il coraggio delle donne armene, impegnate in una lotta immane per la sopravvivenza, inabissate nella profondità delle proprie radici.
Voce narrante per l’intera comunità armena è Antonia, nata in Italia e armena per parte di padre, la quale, riversa i ricordi che i suoi familiari, in particolare nonno Yerwant, le raccontavano da bambina, in una narrazione intimamente storica, nella quale si intrecciano momenti privati sereni, narrati con uno stile piano e scorrevole, che apre a descrizioni ineffabili di uno spaccato socio-culturale, in cui convivono opulenza e grandi valori umani, ad altri drammatici, faticosamente esprimibili, eppure espressi con una scrittura asciutta e composta, quelli dell’eccidio e della deportazione.
Nella prima parte del romanzo conosciamo i componenti della famiglia. In primo luogo, Hamparzum, il capostipite, che sta per morire, sognando di ricongiungersi alla sua amata Iskuhi, ma, all’improvviso: «la mente gli trasmette una cristallina, lucida visione d’orrore e di disperazione (…) La visione certa dell’amata scompare; al suo posto si affacciano i neri cavalieri dell’Apocalisse, suggerendo infauste immagini di annichilimento, nell’assenza oscura di un Dio», fino al «Fuggite, fuggite!» (p. 31), estremo rantolo del morente Hamparzum, profezia di un futuro che avanza, e che dilanierà corpi e sogni e silenzi dei suoi discendenti.
Ed eccoli i discendenti di Hamparzum protagonisti della storia: i figli Yerwant, medico, partito a tredici anni per l’Italia; Zareh, medico ad Aleppo; Sempad, farmacista, rimasto nella città natale con la sua numerosa famiglia, la moglie Shushanig, i figli Suren, il maggiore, che sognava l’Europa e stava per partire, Garo, il secondo, istintivo e taciturno, Leslie, che aveva trovato un rifugio sicuro dove riporre la sua fragilità, poi Arussiag, Henriette e Nubar, «due femmine e un maschietto-vestito-da-donna, (…) gli scampati di Aleppo» (p. 24). Sono loro, e solo loro arriveranno in Occidente, raccontando con i loro sguardi liquefatti ciò che avevano visto, stretti nei legacci di una colpa segreta: quella di essere sopravvissuti.
Sopravvissuti alla deportazione. Come? Il racconto scorre dalle prime sensazioni di una situazione politica ingravescente alla convocazione in Prefettura di tutti gli uomini del paese, alla certezza, per Sempad e la sua famiglia, di essere al sicuro lì, nella masseria delle Allodole, la loro antica casa sulle colline dell’Anatolia. Qui che si compie il Tempo disumano della brutalità e della violenza: la descrizione dell’eccidio è cruda e irripetibile. «Come avviene una strage? (…) La casa si offre all’ospite, senza difese, innocente come Sempad, il suo padrone» (pp. 100-101). Anche il destino delle donne sembra segnato, un destino di violenze e stupri, pietosamente evitato dall’intervento del colonnello Hikmet che, avvertito da Ismene, una lamentatrice greca molto vicina alla famiglia, arriva alla masseria. Egli è al corrente del destino che sarà riservato agli armeni, ma li conosce tutti; è un militare d’altri tempi, «Il suo mestiere è la guerra, ma non ama le stragi» (p. 108). Crede ancora di essere al comando, fa disarmare gli assassini accusandoli di insubordinazione; cerca in giro gli armeni che è andato a salvare, ma non ne vede nessuno, «trova Shushanig (…) e intorno a lei le altre donne della famiglia, solo donne, che lo guardano con occhi immobili. È un quadro di tragica inerme compostezza femminile, che fa capire immediatamente l’accaduto all’ufficiale. “Gli uomini non ci sono, dunque li hanno già uccisi”» (p. 108). A quel punto, Hikmet decide di schierarsi, perché non tutto sia perduto: porge il braccio a Shishanig e rispettosamente le dice di tornare a casa e di confidare in lui. «Shushanig, spezzata, lo segue fino alla carrozza. Non piangerà che in quell’ora, tornando indietro, e poi, mai più. Durante la deportazione, sarà dura, come una leonessa» (p. 109).
Ed ecco la deportazione: un proclama concede trentasei ore alle famiglie armene, composte ormai da sole donne, per lasciare la città e i loro beni. Saranno scortate dai soldati fino in Siria. «Nessuno, nella piccola città, tranne le donne della famiglia, sospetta che ci sia dell’altro, percepisce il gigantesco inganno, la trappola mortale, l’andare verso il nulla che sarà la vera meta del viaggio; nessuno sa che gli uomini sono stati già cancellati» (p. 126).
Il colonnello Hikmet, che tante soluzioni ha progettato per aiutare Shushanig e le sue donne, non conosce i dettagli della deportazione, stabiliti a sua insaputa dagli ufficiali dell’Organizzazione speciale al diretto comando del “kaymakam”. E i carri sono partiti. Shushatig e le sue donne sono partite!
Il drammatico racconto delle vicissitudini della «miserabile processione» occupa la seconda parte del libro.
Dopo che un’incursione di una tribù curda a cavallo ha portato via carri, vite e speranze di sopravvivenza, le donne sono abbandonate a se stesse e al volere dei gendarmi: «si contano le forze, e tutti quei semplici cuori chiedono a se stessi e ai loro santi il coraggio di continuare a esistere» (p. 147). Sono stremate, ammalate, sporche, vestite di stracci, affamate e assetate. Continuano a camminare le madri armene, senza dare più senso ai loro passi: «tutti i vecchi e le vecchie un po’ alla volta scompaiono, durante la marcia; si tolgono di mezzo semplicemente fermandosi. Nessuno li cerca, nessuno gli chiede di continuare» (p. 152).
Ecco nei pressi della città di Konya, qualche carretto, dei gruppetti di gente ai lati della strada: «gridano le armene, piangono i loro bambini con ritrovata voce, gemono sommessi i pochi vecchi superstiti. E gli abitanti di Konya capiscono tutto» (p. 161) e li aiutano, autorizzati dai capi spirituali di quella città.
Ad Aleppo avviene l’avventuroso salvataggio di Shushanig. Ismene, che ha seguito dall’esterno il penoso cammino dei deportati, ritrova la sua signora. Ad Aleppo vive Zareh, fratello di Sempad: è un medico e lavora all’ambasciata francese. A lui Ismene racconta tutto: «Alla luce quieta della lampada ad acetilene, gli orrori di cui parla assumono quasi una fisica realtà. I fantasmi del fratello, degli amici, del popolo intero della piccola città si affollano, pietosi, ciascuno cercando di narrare la sua storia» (p. 202). Fu così che le figlie di Sempad e Nubar, il maschietto-vestito-da-donna, sopravvissero, giungendo, circa un anno dopo, a Venezia, da Yerwant, il fratello italiano di Sempad, colui che progettava invano di raggiungere il suo paese natale. «Il cuore di Yerwant si chiude, si sigilla per sempre. Oppresso da un infinito senso di colpa (…) Yerwant non scenderà mai più di sua volontà nelle radici della sua appartenenza, nei musicali colorati ricordi del Paese Perduto, mai più fino a quando li racconterà alla bambina come fiabe lontane, forse inaccessibili, forse sognate» (p. 139).

 Condividi
Condividi