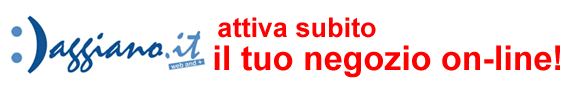È il Tarentini il primo a occuparsi di questo luogo di culto, scrivendone nel suo “Manduria Sacra”

La recente apertura della cappella della Pietà, in occasione della XXXI edizione della manifestazione nazionale Chiese Aperte, a cura della sede Archeoclub, ci dà modo di scrivere sulle caratteristiche della chiesetta, soffermandoci su suoi aspetti storico-artistici.
È il Tarentini il primo a occuparsi di questo luogo di culto, scrivendone nel suo “Manduria Sacra” (Ed. Barbieri, 2000). Nell’Opera citata, il primo riferimento ad essa è contenuto negli atti della visita del Vescovo Francia nel 1698, in cui si distinguono due cappelle «ambe sotto lo stesso titolo», distinte solamente dalla loro posizione: la Cappella di cui scriviamo è indicata come “Extra moenia medium miliare” ( = mezzo miglio fuori le mura), mentre un’altra cappella della Pietà sorgeva dove attualmente troviamo la Chiesa di Santo Stefano. La chiesetta di nostro interesse si trova a sud della città, proprio nel luogo dove, in occasione della processione penitenziale di San Pietro da Bevagna a Manduria (svoltasi recentemente), avviene la consegna dell’effigie del Santo al Sindaco, con la  sottoscrizione del verbale a garanzia del ritorno (foto 1). Dalle informazioni riportate dal Tarentini, sappiamo che la cappella è lunga 7 metri e mezzo, larga 3 e mezzo (foto 2); ha un solo altare, sulla cui parete insisteva, un tempo, un affresco raffigurante Cristo morto sulle ginocchia di Maria Addolorata, sostituito (perché coperto con calce), nel 1856, da una tela riportante lo stesso soggetto, ad opera del pittore locale Gaetano Saracino (foto 3); presenta due affreschi ai lati dell’altare, uno raffigurante Santa Lucia (foto 4), l’altro San Leonardo abate (foto 5). Lo stesso Autore scrive di un beneficio legato alla chiesetta dalla famiglia Ricchiuti, passato successivamente al Seminario diocesano, mentre al 1680 ne godeva l’arciprete Castorio Sorano.
sottoscrizione del verbale a garanzia del ritorno (foto 1). Dalle informazioni riportate dal Tarentini, sappiamo che la cappella è lunga 7 metri e mezzo, larga 3 e mezzo (foto 2); ha un solo altare, sulla cui parete insisteva, un tempo, un affresco raffigurante Cristo morto sulle ginocchia di Maria Addolorata, sostituito (perché coperto con calce), nel 1856, da una tela riportante lo stesso soggetto, ad opera del pittore locale Gaetano Saracino (foto 3); presenta due affreschi ai lati dell’altare, uno raffigurante Santa Lucia (foto 4), l’altro San Leonardo abate (foto 5). Lo stesso Autore scrive di un beneficio legato alla chiesetta dalla famiglia Ricchiuti, passato successivamente al Seminario diocesano, mentre al 1680 ne godeva l’arciprete Castorio Sorano.
Riguardo l’anno di costruzione, alla luce di nuovi studi, l’affermazione del Tarentini «Quando e da chi fu eretta s’ignora assolutamente ma dall’ordine della costruzione si può congetturare che la sua esistenza rimonti al 1600» (p. 66), può essere meglio precisata.
Infatti, lo studioso Nicola Morrone, che ha illustrato gli aspetti storico-artistici della Cappella durante la citata manifestazione ‘Chiese Aperte’, ha potuto verificare, in seguito a ricerche d’archivio da lui compiute, quanto ipotizzato dal Tarentini, fino a precisare “ad annum” la datazione della cappella.
Cappella durante la citata manifestazione ‘Chiese Aperte’, ha potuto verificare, in seguito a ricerche d’archivio da lui compiute, quanto ipotizzato dal Tarentini, fino a precisare “ad annum” la datazione della cappella.
Le informazioni che seguono sono tratte dall’esposizione del prof. Morrone rivolta ai visitatori presenti nella cappella, durante la manifestazione Archeoclub (foto 6).
Egli ha ritrovato, nell’Archivio di Stato di Taranto, i protocolli del notaio GiovanBattista Erario, attivo su Manduria nel sec. XVII. Nel protocollo del 1611, alla carta 181 recto, è riportato che nei primi mesi dello stesso anno, per volere di Donato Ricchiuti, fu edificata in Casalnuovo una cappella lungo la via che porta al mare (San Pietro in Bevagna), “intitolata sub vocabulo la Madonna dello Spasimo, seu della Pietà”, stabilendovi altresì un rettore o un cappellano che già dal ‘600 celebrava regolarmente la messa. Presumibilmente, ciò avveniva alla presenza della sola famiglia Ricchiuti, viste la ridotte dimensioni della chiesetta, usufruita probabilmente come Cappella gentilizia. E non poteva essere altrimenti, visto che nell’atto notarile, rogato nel luglio 1611, è confermato il “beneficio” che il Ricchiuti stabilisce “pro remedio animae meae” (= ‘per la cura della mia anima’) e dei propri discendenti.
 Dal punto di vista architettonico, la Cappella consta di un vano parallelepipedo, orientato ecclesialmente, cioè secondo la direttrice ovest-est / ingresso-altare (nei luoghi di culto cristiani delle origini, l’altare è rivolto a est perché simboleggia il sorgere del sole, la risurrezione di Cristo e la luce di cui Egli è portatore; il sacerdote celebrava la messa con le spalle ai fedeli). Esso è diviso in due campate quadrangolari, sorrette da volte a spigolo (foto 7, tipologia di volta successiva a quella a botte, e documentata a Manduria non prima del ‘600), chiuse rispettivamente da due chiavi di volta aventi una forma di rosetta (foto 8) l’altra di cherubino (foto 9). Il vano è illuminato da due piccole finestre, in direzione nord-sud, mentre alcuni segni riscontrati all’esterno, sopra il portone d’ingresso, fanno supporre una terza finestra, verosimilmente murata (come spesso in passato) per ragioni statiche. È presente un’acquasantiera in pietra (foto 10) e una nicchia dove venivano riposti gli oggetti sacri, dopo la funzione liturgica.
Dal punto di vista architettonico, la Cappella consta di un vano parallelepipedo, orientato ecclesialmente, cioè secondo la direttrice ovest-est / ingresso-altare (nei luoghi di culto cristiani delle origini, l’altare è rivolto a est perché simboleggia il sorgere del sole, la risurrezione di Cristo e la luce di cui Egli è portatore; il sacerdote celebrava la messa con le spalle ai fedeli). Esso è diviso in due campate quadrangolari, sorrette da volte a spigolo (foto 7, tipologia di volta successiva a quella a botte, e documentata a Manduria non prima del ‘600), chiuse rispettivamente da due chiavi di volta aventi una forma di rosetta (foto 8) l’altra di cherubino (foto 9). Il vano è illuminato da due piccole finestre, in direzione nord-sud, mentre alcuni segni riscontrati all’esterno, sopra il portone d’ingresso, fanno supporre una terza finestra, verosimilmente murata (come spesso in passato) per ragioni statiche. È presente un’acquasantiera in pietra (foto 10) e una nicchia dove venivano riposti gli oggetti sacri, dopo la funzione liturgica.
L’esterno si presenta piuttosto umile nel suo aspetto, la porta d’ingresso con cornice piatta è sormontata da una fila di beccatelli che si interrompe, a tratti, sui muri laterali e da una seconda linea, scorniciata, che chiude la costruzione. In mezzo alle due cornici, due rosette si alternano ad altri segni, mentre foglie di acanto si trovano sia agli spigoli che ai margini dei due lati. È presente uno scolatoio in pietra. Lungo il muro sud della Cappella, ormai privo di intonaco, numerose “croci incise” ci raccontano storie di fede e devozione: sono croci votive lasciate dai fedeli, oppure, in fase di costruzione della chiesa, dallo stesso clero. Le ‘croci incise’ hanno molteplici significati: testimonianza di devozione religiosa, marcatura di un luogo sacro, celebrazione di eventi storici.
 Da un punto di vista storico-artistico, ai lati dell’altare troviamo i due dipinti, verosimilmente pitture murali a secco (già menzionati dal Tarentini, che però li chiama affreschi. Una tecnica, quella dell’affresco, che richiede notevole perizia e tempi estremamente lunghi per l’asciugatura delle zone dipinte). Le due figure, secondo il Morrone, sono contemporanee alla costruzione della cappella. Esse si trovano in posizione frontale rispetto all’osservatore, tanto da poterle definire ‘iconiche’, in quanto rappresentano semplicemente il santo, senza ‘raccontare’ alcuna storia. Questa soluzione stilistica, rispetto a quella di un dipinto narrativo, di cui è da comprendere la storia, veicola il messaggio di fede in maniera più immediata al fedele in preghiera, ma è anche indice di un attardamento stilistico, per la persistenza, ancora nel primo decennio del 1600 di elementi tipici rinascimentali: ne è un esempio, oltre alla staticità delle figure, anche la centinatura che presentano i due dipinti. Sulla parete d’altare è collocata la tela raffigurante il Cristo deposto sulle ginocchia di Maria, che è posta al centro, San Giovanni a sinistra e la Maddalena a destra. Da questo dipinto, che riprende quello murario non più visibile, deriva il nome con il quale è indicata la Cappella nel documento d’archivio citato dal prof. Morrone, “Madonna dello spasimo”: lo sguardo di Maria, infatti, è rivolto verso il cielo a esprimere uno stato di afflizione indicibile, uno spasimo appunto. Sullo sfondo un calvario con tre croci, e in basso a sinistra la corona di spine con i chiodi. Pur trattandosi di una tela di carattere popolare, il pittore Saracino presenta un buon senso della composizione; egli chiaroscura solo i punti essenziali, per mettere in evidenza il soggetto principale della scena, in modo che il visitatore entrando fissi subito il proprio sguardo su quello della Madonna.
Da un punto di vista storico-artistico, ai lati dell’altare troviamo i due dipinti, verosimilmente pitture murali a secco (già menzionati dal Tarentini, che però li chiama affreschi. Una tecnica, quella dell’affresco, che richiede notevole perizia e tempi estremamente lunghi per l’asciugatura delle zone dipinte). Le due figure, secondo il Morrone, sono contemporanee alla costruzione della cappella. Esse si trovano in posizione frontale rispetto all’osservatore, tanto da poterle definire ‘iconiche’, in quanto rappresentano semplicemente il santo, senza ‘raccontare’ alcuna storia. Questa soluzione stilistica, rispetto a quella di un dipinto narrativo, di cui è da comprendere la storia, veicola il messaggio di fede in maniera più immediata al fedele in preghiera, ma è anche indice di un attardamento stilistico, per la persistenza, ancora nel primo decennio del 1600 di elementi tipici rinascimentali: ne è un esempio, oltre alla staticità delle figure, anche la centinatura che presentano i due dipinti. Sulla parete d’altare è collocata la tela raffigurante il Cristo deposto sulle ginocchia di Maria, che è posta al centro, San Giovanni a sinistra e la Maddalena a destra. Da questo dipinto, che riprende quello murario non più visibile, deriva il nome con il quale è indicata la Cappella nel documento d’archivio citato dal prof. Morrone, “Madonna dello spasimo”: lo sguardo di Maria, infatti, è rivolto verso il cielo a esprimere uno stato di afflizione indicibile, uno spasimo appunto. Sullo sfondo un calvario con tre croci, e in basso a sinistra la corona di spine con i chiodi. Pur trattandosi di una tela di carattere popolare, il pittore Saracino presenta un buon senso della composizione; egli chiaroscura solo i punti essenziali, per mettere in evidenza il soggetto principale della scena, in modo che il visitatore entrando fissi subito il proprio sguardo su quello della Madonna.
Interessante e tutto da scoprire si presenta l’altare, sul quale è presente la pietra sacra. Quello che vorrebbe sembrare un paliotto d’altare presenta un partito decorativo a fasce che è stato preso sicuramente altrove e riutilizzato (foto 20). Inserito, in maniera capovolta, un bellissimo panneggio, verosimilmente per fingere un tessuto. Inoltre nella parte laterale destra possiamo leggere, in due distinte righe, una scritta, incomprensibile nel suo significato, perché incompleta: QUAM DELERAT OPUS S. MAT.P. (Manca il seguito) HAEC SACRA DONATI PTI. STAT PIETAT (manca il resto).
La manutenzione della Cappella, quasi in stato di abbandono per tutto il XIX secolo, viene ad un certo punto affidata a tal Vincenzo Sergi, il quale dispone l’impegno per il futuro di tutti i discendenti maschi della famiglia Sergi a custodire la cappella nel migliore dei modi. Così è stato fino agli anni 80 del 1900, con l’apertura della cappella in occasione della solennità della Madonna della Pietà (prima domenica dopo Pasqua). In tale occasione, i fedeli aspettavano impazienti i festeggiamenti: la celebrazione del messa al mattino, nel pomeriggio la statua della Madonna della Pietà della parrocchia di San Michele Arcangelo giungeva in processione fino alla Cappella, accolta dalla banda musicale e dalle preghiere dei presenti, veniva rivolta verso l’interno per poi proseguire il percorso previsto. Intanto piante e fiori profumati adornavano il piccolo vano, fuori si distribuivano immaginette sacre della Madonna, i bambini stringevano forte il filo del palloncino appena comprato, gli adulti preparavano i fuochi di artificio, la cui accensione avveniva nella piccola pineta che ancora oggi si trova di fronte la Cappella. È la «festicella» si cui scrive il Tarentini (p. 66). La cappella veniva altresì aperta durante la processione di San Pietro, sia quando l’effige del Santo entrava in paese da Bevagna (la Madonna accoglieva il Santo), sia quando la si riportava al santuario (il Santo salutava la Madonna). (Testimonianza della signora Candida Sergi, attuale custode della Cappella).






 Condividi
Condividi