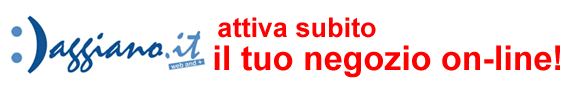Il “Progetto dei lavori di adattamento e riduzione di una parte del convento dei Domenicani ad ospedale civile” venne redatto dall’architetto leccese Giuseppe Maenza nel luglio 1872

La Congregazione di Carità dovette avviare una procedura particolare, per poter modificare la volontà testamentaria di Marianna Giannuzzi, dimostrando che i benefici apportati ai malati poveri dalle attività svolte dal Monte di Misericordia, peraltro con ingenti spese, venivano vanificati dalla mancanza di un “ricovero” confacente alle condizioni di salute del malato. L’unico modo per aderire pienamente alle intenzioni della testatrice era fondare un ospedale, dove gli ammalati indigenti avrebbero avuto medico, farmaci e assistenza continua nello stesso luogo.
Prima che l’ospedale fosse ufficialmente fondato, trascorse oltre un decennio, durante il quale la Congregazione di Carità continuò regolarmente a soccorrere i poveri bisognosi del comune, utilizzando le rendite del Monte di Misericordia. Era febbraio del 1872 quando gli amministratori della Congregazione (Camillo Capocelli, Teodoro Lacaita, Annibale Arnò, Saverio Polverino e Cataldo Barberio) deliberarono l’impianto di un ospedale in Casalnuovo, da allogare nei locali dell’ex convento dei domenicani, soppresso nel 1809 e rimasto di proprietà comunale.
Il “Progetto dei lavori di adattamento e riduzione di una parte del convento dei Domenicani ad ospedale civile” venne redatto dall’architetto leccese Giuseppe Maenza nel luglio 1872. Dall’elaborato (seppur giuntoci incompleto) si evince che la spesa stimata per lavori di muratura e falegnameria nella parte di convento in questione, cioè quella posta a nord, sia al piano terra che al primo piano, è di lire 3250.
Terminati i lavori di adattamento e ottenuta l’approvazione definitiva dell’impianto da parte della Deputazione provinciale di Terra d’Otranto, l’ospedale cominciò a funzionare.
Siamo nel 1873, come si legge nell’iscrizione presente nella sala d’ingresso, dettata dal sacerdote Saverio Polverino: “A MARIANNA GIANNUZZI / CHE MAGNANIMA / DEL SUO LARGO PATRIMONIO FECE DONO AI POVERI / LA CONGREGAZIONE DI CARITA’ DI MANDURIA / QUESTO OSPEDALE / DOPO LXXVII ANNI CONSACRA RICONOSCENTE / E LO INTITOLA DEL NOME VENERATO / DI LEI / MDCCCLXXIII”.
L’ospedale contava su un organico di due medici, Alessandro Ponno e Giuseppe Sbavaglia (che già in precedenza prestavano le cure a domicilio), e delle suore Figlie della Carità, la cui presenza nel pio stabilimento venne deliberata dalla Congregazione di Carità nel settembre 1873. La gestione della farmacia ospedaliera fu affidata alla direttrice delle Figlie della Carità, suor Maria Farnerari, la quale doveva attenersi in maniera scrupolosa ad un regolamento interno e annotare su appositi registri le ricette con le prescrizioni mediche. Naturalmente tutte le spese sostenute dovevano essere approvate con apposite deliberazioni: per la farmacia, alcool e droghe diverse utilizzate nella preparazione dei rimedi farmacologici, vino, zucchero, sciroppo di gelsi, preparati chimici (solfato di chinino, solfito di magnesio, tintura di iodio, acido borico, ammoniaca, acqua di catrame), per l’ospedale, vitto per gli ammalati, acquisto di legna e carbone, candele e fiammiferi, sapone, bucati e barbiere per gli infermi, vitto fornito agli ammalati poveri a domicilio, ostie e cera per la cappella.
Sì, perché l’antico refettorio del convento fu adibito a tale uso religioso. La cappella ha forma rettangolare e presenta un’area di 19 mq. Il Tarentini (“Manduria Sacra”, 171) ci informa che è presente un solo altare in legno (anticamente in pietra); che la cappella è dedicata alla Vergine Immacolata, rappresentata su una tela, opera di Francesco Galeone di Francavilla, successivamente allocata sotto la lapide dedicata a Marianna Giannuzzi nella sala d’ingresso, mentre nella cappella è stata collocata una pregevole statua della Madonna Miracolosa. Nelle foto a corredo del presente articolo, si può vedere la cappella come si presenta attualmente.
Nei primi anni di vita, la struttura dell’ospedale subì alcune modifiche, fra le quali l’acquisto, nel 1879, di un giardino adiacente. Diverse le motivazioni: l’insufficiente quantità di acqua a disposizione per mancanza di suolo dove realizzare una cisterna; i benefici per i degenti convalescenti di respirare aria pulita; la possibilità di avere a disposizione una discreta quantità di alberi da frutto ivi piantati (noci, mandorli, melograni, fichi e altro).
La terza e ultima parte sarà pubblicata domani.
Bibliografia
D’Ippolito Lucia, “L’ospedale ‘Marianna Giannuzzi’ di Manduria: le origini” in “Liber amicorum – Miscellanea di studi storici offerti a Rino Contessa”, a cura di Giovangualberto Carducci, Filo editore, 2 voll. tomo I, pp. 413-466; Brunetti Pietro, “Manduria tra storia e leggenda – dalle origini ai giorni nostri”, Barbieri/Selvaggi editori 2007; Tarentini L., “Manduria Sacra”, a cura di Elio Dimitri, Barbieri editore 2000; Tarentini L., “Cenni storici di Manduria”, Atesa Editrice, Bologna 1996.
Link prima parte https://www.facebook.com/share/p/1C1p8G9tAs/



 Condividi
Condividi