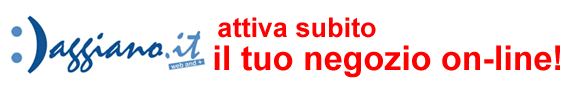La poesia di Cosimo Greco è dedicata alle nuove generazioni «ché possano amare la terra amata e amara dei padri»
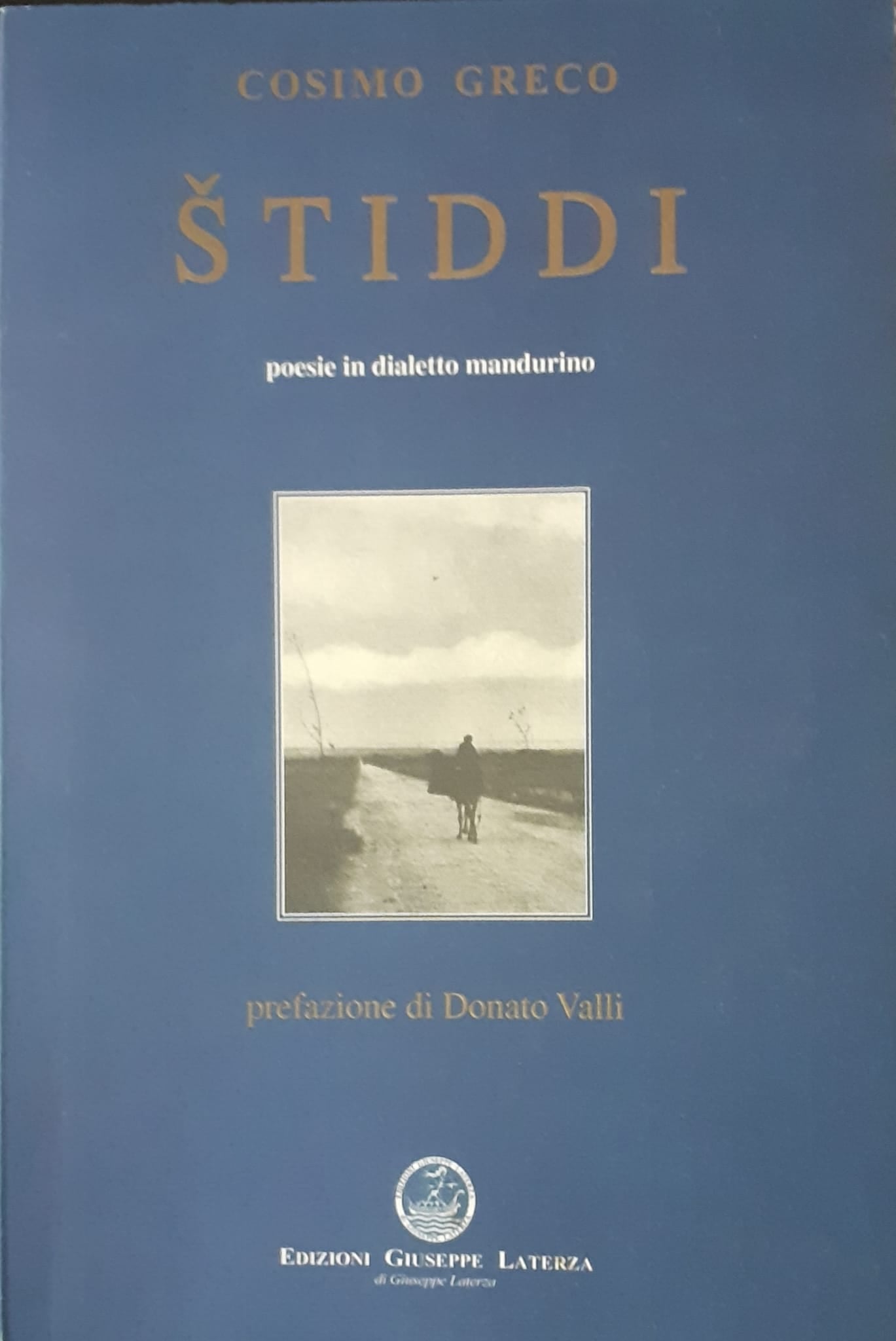
«Ciò che esclude per lungo tempo la ragione, può, in breve, determinare il sentimento» — così scrive il poeta, da sempre restio alla pubblicazione di poesia in dialetto mandurino, non essendoci mai stata una tradizione letteraria di questo tipo a cui fare riferimento. Poi… “Štiddi”. È il sentimento del poeta che prende voce dunque, per dare all’oggi, così poco generoso nei confronti del patrimonio linguistico dialettale, una chiara risposta alla confusione ingeneratasi tra progresso (scientifico e tecnologico) e civiltà (conquista morale e spirituale). Di qui, il desiderio dell’autore che la poesia in dialetto possa veicolare quei valori di civiltà e cultura anche in tale registro linguistico. Non solo, proprio la mancanza di riferimenti letterari in quest’ambito, fa sì che l’autore modelli il dialetto della tradizione, arricchendolo di termini nuovi, magari poco dialettali, ma che lo rendono, in tal modo, lingua viva del presente.
La poesia di Cosimo Greco è dedicata alle nuove generazioni «ché possano amare la terra amata e amara dei padri».
Il viaggio del poeta nell’universo di “Štiddi” inizia con “Uci” ( = “Voci”, p. 17), le voci di coloro che furono, voci familiari, vive, di mestieri che non sono più, voci diversamente presenti: «Uci ti casa mia / cantu ti naca / tessi la ècchja mia allu tularu / canta lu jadduzzu trapularu (…) uci senza ritegnu / ca jaštemunu all’annata / pi lla ntrata (…) la oci ti lu conzalimmi / enchj l’aria ti crašti (…) / uci ti sapunaru / ti siggiaru / ti craunaru (…)». Traduzione a lato: “Voci di casa mia / canto di culla / tesse la vecchia mia al telaio / canta il galletto intrigante (…) Voci senza ritegno / che bestemmiano all’annata per il raccolto (…) la voce del conciabrocche / riempie l’aria di vasi di fiori (…) voce di saponaio / di seggiolaio / di carbonaio”.
La prima parte dell’opera termina con “Lu tastamentu” (= “Il testamento”, p, 57): «S’è ffatt’a zinzuli la sciurnata / s’è fattu spuntu lu cielu / e štu filu ti luci sfoca / a mmanu a mmanu (…) / Torna cumpagna mia / pi tastamentu / torna francidda / ddo la ecchja canta / alla sulagna / e la muscia sciòca / cu lli šteddi / e sciòca / e zzumpa e bballa / e ccanta alla luna / ca jè puisia (…) / Puèi ffitimi allu jentu / cu mmi porta / cchju lluntanu ti lu soli /e mmo / cujimu li zzannoli / e sciamu». Trad.: “S’è fatta a brandelli la giornata / s’è fatto diverso il cielo / e questo filo di luce sfoca / a mano a mano (…) Torna compagna mia / per testamento / torna fringuella / dove la vecchia canta / al sole / e la gatta gioca / con le stelle / e gioca / e salta e balla / e canta alla luna / che è poesia (…) Poi affidami al vento / che mi porti / più lontano del sole / ed adesso / raccogliamo le masserizie / e andiamo”.
Nel mezzo dell’opera, due figure cariche di fatica: quella di Angiolina nella poesia “Šti to cucchi” ( = “Queste due sole, p. 33”): «All’arbi / l’Ancilecchia parti /a uarda/ e lu cuccu / pi lla štrata la ccumpagna» (“All’alba l’Angiolina parte / a sella / e il “cuccu” / per la strada l’accompagna)” e quella di “Lu Tori Scarpagrossa” nell’omonima poesia (p. 35) che «ogni ddia (…) mena li pieti alla štrata e no ssi lagna (…) riccu ti setti fili nci uatagna” (“ogni dì / getta i piedi alla strada / e non si lagna (…) ricco di sette figli ci guadagna”); il tutto sotto lo sguardo pieno di ricordi di “Lu uecchj ti lu tiempu” ( = “L’occhio del tempo”, p. 47): “Cercu štasera alla luna / malandrina /lu tiempu ti la rena / e di lu truddu / e canti ti ficàri alla Marina” (Chiedo stasera alla luna / malandrina / il tempo della rena / e del trullo / e canti di ficàri alla Marina”).
“Štiddi” continua con i “frummèdduli” (frammenti) e si conclude con “… e farballài” (… e “a margine”).

 Condividi
Condividi